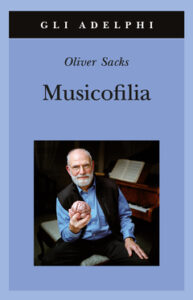Un’intervista a Leonetta Bentivoglio a cura di Federica Evangelisti
Ho intervistato Leonetta Bentivoglio, scrittrice e giornalista italiana che ha avuto nel suo passato esperienze di danzatrice e coreografa. È stata storico della danza e autrice di volumi sulla danza contemporanea e sul teatrodanza di Pina Bausch. Ha collaborato con diverse testate e scrive dagli anni Ottanta sulle pagine di Cultura e Spettacoli del quotidiano La Repubblica. Per alcuni anni ha fatto il critico di danza. Attualmente si occupa soprattutto di musica classica e di letteratura con interviste e recensioni.
1) Come mai ha scelto di fare la giornalista e soprattutto, all’inizio del suo percorso, di focalizzarsi sulla danza?
“Voglio chiarire subito una cosa: oggi non lavoro più nell’ambito della danza. Ma è vero che ho iniziato il mio itinerario professionale come storico e critico di danza. Ho seguito sempre, fin da ragazzina, le arti dal vivo: musica, danza e teatro. Parallelamente ho sempre amato moltissimo scrivere.
Mi sono laureata in Filosofia negli ultimi anni Settanta, e mentre stavo all’Università ho cominciato a collaborare con “Il Manifesto”.
Io stessa studiavo danza. Durante la mia giovinezza ho frequentato classi quotidiane di danza contemporanea e sono stata attratta soprattutto dai linguaggi del Novecento, secolo lungo il quale sono nate nuove tecniche e nuovi stili alternativi al balletto classico-accademico. Il fatto di scrivere sulla danza coniugava le mie due maggiori passioni.
Dopo la laurea in Filosofia, presa a Roma, sono andata negli Stati Uniti dove ho coltivato molto il mio interesse per la danza contemporanea. Ho trascorso un periodo piuttosto lungo a New York studiando in prima persona le tecniche di Martha Graham e di Merce Cunningham, due tra i massimi coreografi americani del ventesimo secolo. Ho scritto un libro, “La Danza Moderna”, pubblicato da Longanesi, che poi, negli anni Ottanta, è stato rivisto, ampliato e riproposto dallo stesso editore con un altro titolo, “La Danza Contemporanea”. Si trattava dell’unico libro esistente sui linguaggi emersi nel Novecento, ed ebbe una certa diffusione. Grazie al suo piccolo successo, ho iniziato a collaborare con “L’Espresso” per poi passare a “Repubblica”.
Ciò che mi preme segnalare è che mi sono dedicata al lavoro di critico di danza, in maniera intensa e a tempo pieno, soltanto fino agli anni Novanta. Dopo sono stata assunta nella redazione culturale della “Repubblica”, dove scrivo da decenni. Anche adesso che sono in pensione, continuo a lavorare per “Repubblica” come collaboratrice esterna. Per molto tempo ho lavorato all’interno della redazione, e ovviamente, stando dentro un giornale, non ci si può occupare soltanto di danza. Mi sono quindi dedicata pure ad altri settori, approfondendo quelli che erano già i miei interessi. Avevo seguito e anche studiato la musica, ed ero stata sempre una fortissima lettrice di romanzi. Da vari anni, ormai, mi occupo giornalisticamente di musica classica, di lirica e di letteratura. Credo di potermi definire una giornalista culturale. Leggi tutto “Grand Jeté verso la scrittura”