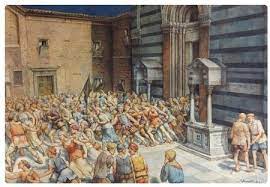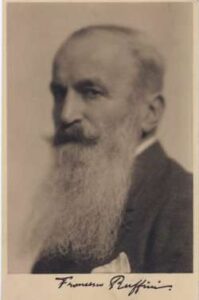di Matilde Petretti e Silvia Barsotti
Mare fuori è una serie televisiva di Ivan Silvestrini e Carmine Elia che ci ha molto colpito e ci ha fatto capire alcuni aspetti della società di oggi. Questa serie tv ha come sigla una canzone che esprime al meglio il suo significato. Questa sigla è stata scritta da Stefano Lentini e poi successivamente reinterpretata da un attore. Il titolo della canzone, ma anche della serie, Mare fuori, esprime infatti l’essenza di quest’ultima, racchiudendo in due parole quanto gli autori hanno cercato di trasmettere.
La vicenda è ambientata nel carcere minorile di Napoli, istituto penitenziario minori, nonché IPM, luogo che si lascia alle spalle la città difficile e il mare davanti, vicino e sfuggente, irraggiungibile, inteso come bellezza e libertà. Fuori, appunto, dalla loro portata. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi, alcuni originari di Napoli altri invece di altre città, che si ritrovano all’IPM: tra di essi c’è chi sbaglia con la precisa volontà di farlo, chi non si rende conto della gravità dei suoi atti e chi è convinto che il vero sbaglio sia farsi arrestare, e non compiere un reato.
Dalle loro celle, i ragazzi assistono all’impeto delle onde e mantengono vivo il desiderio di libertà. La direttrice Paola Vinci e il comandante della polizia penitenziaria Massimo Valenti si impegnano per rimetterli sulla buona strada e a tracciare per loro un futuro migliore mettendoli in condizione di saper affrontare le numerose avversità che dovranno incontrare durante il loro cammino. Leggi tutto “Attraverso le sbarre il mare”