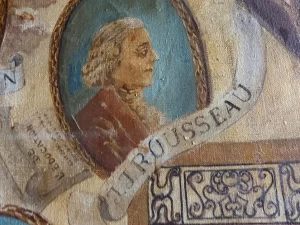di Matilde Cianchi
L’amore, uno dei sentimenti più potenti e universali, è stato oggetto di riflessione e ispirazione per poeti e scrittori di ogni epoca. Tra le opere d’amore più celebri nella storia della letteratura, troviamo i versi di Catullo dedicati alla sua amante Lesbia, la sua musa ispiratrice. Mentre le vicende personali di Catullo e Lesbia appartengono a un’epoca lontana, l’essenza dei loro sentimenti può essere reinterpretata e compresa anche nella società di oggi. Publio Valerio Catullo, un poeta romano vissuto nel I secolo a.C., fu uno dei primi ad esprimere sentimenti personali attraverso la poesia. Catullo si innamorò follemente di una donna di nome Clodia, che lui chiamò Lesbia nelle sue opere. Catullo descrisse questa storia d’amore nelle sue poesie, rivelando la sua anima vulnerabile e l’incapacità di resistere alla tentazione di Lesbia nonostante le sofferenze che lei gli infliggeva. La loro relazione può essere considerata un esempio classico di un amore irrazionale e passionale che trascende la ragione stessa. Leggi tutto “Una reinterpretazione moderna dell’amore fra Catullo e Lesbia”